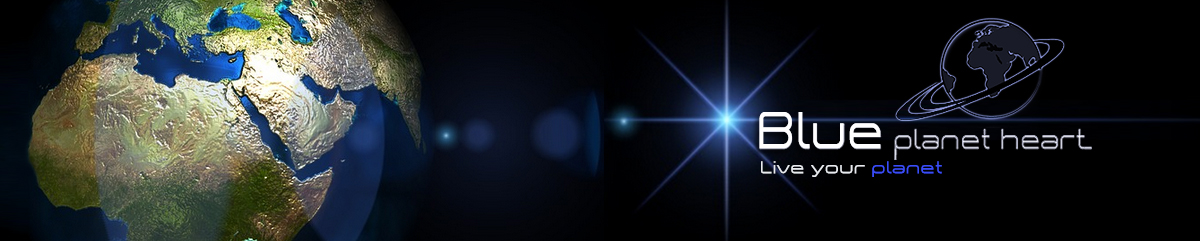La radioattività potrebbe sostenere la vita nelle profondità della Terra
La dissociazione delle acque sotterranee provocata dal decadimento di elementi radioattivi sembra sostenere giganteschi ecosistemi al di sotto della superficie terrestre. E questo processo potrebbe verificarsi anche su altri pianeti
di Jordana Cepelevic/Quanta Magazine
www.lescienze.it
Gli scienziati sondano costantemente i margini e i confini della zona di abitabilità, in cerca dei limiti della vita. Per questo hanno scavato tunnel sotterranei a chilometri di profondità, effettuando perforazioni dal fondo dei pozzi minerari e carotaggi profondi dei sedimenti oceanici. Con loro grande sorpresa, “c’era vita in tutti i posti dove siamo andati a vedere”, ha detto Tori Hoehler, chimico e astrobiologo all’Ames Research Center della NASA. E c’era in quantità stupefacente: secondo varie stime, il regno dei viventi sub-superficiali occupa un volume doppio di quello degli oceani e contiene un numero di cellule dell’ordine di 1030; vale a dire che si tratta di un habitat fra i più vasti, e anche fra i più antichi e ricchi di biodiversità, del pianeta.
I ricercatori stanno ancora provando a capire come sopravvive la maggior parte degli organismi delle rocce di profondità. La luce solare necessaria per la fotosintesi non arriva sin laggiù, e la scarsa quantità di sostanze organiche sfruttabili come nutrienti che vi giunge spesso si consuma in fretta. A differenza delle comunità di organismi che vivono nei pressi di fumarole idrotermali sul fondo marino, o in regioni continentali riscaldate dall’attività vulcanica, gli ecosistemi di profondità in genere non possono contare sui processi ad alta temperatura che sostentano alcune forme di vita sub-superficiali indipendenti dalla fotosintesi: questi microbi devono tirare avanti al freddo e nel buio più profondo.
Studi pubblicati in febbraio da due diversi gruppi di ricerca sembrano adesso aver risolto almeno in parte questo mistero per le cellule che vivono sotto i continenti e per quelle dei sedimenti marini profondi. I due gruppi hanno infatti trovato prove secondo cui, come le reazioni nucleari del Sole forniscono energia al mondo della superficie, un diverso tipo di processi nucleari – il decadimento radioattivo – può sostenere la vita nelle profondità sotterranee. Le radiazioni provenienti dagli atomi instabili contenuti nelle rocce possono scindere le molecole d’acqua in idrogeno più perossidi e radicali chimicamente reattivi; alcune cellule sono in grado di usare direttamente l’idrogeno come combustibile, e i restanti prodotti trasformano minerali e altri composti circostanti in ulteriori fonti di energia.

Anche se queste reazioni radiolitiche forniscono energia assai più lentamente del Sole e dei processi termali di profondità, i ricercatori hanno mostrato che sono abbastanza rapide da svolgere un ruolo essenziale nell’alimentare l’attività microbica in una vasta gamma di ambienti; e che a esse si deve l’esistenza di un diversificato serbatoio di molecole organiche e altre sostanze chimiche importanti per la vita. Secondo Jack Mustard, geologo planetario alla Brown University, non coinvolto nelle nuove ricerche, la spiegazione che chiama in causa la radiolisi ha “rivelato un panorama nuovo” della diversità delle forme di vita, e anche sul modo in cui la vita stessa potrebbe essere emersa sulla Terra primordiale e in altri luoghi dell’universo in cui, un giorno, potremmo trovarla.
Idrogeno nelle profondità del sottosuolo
Barbara Sherwood Lollar si è iscritta all’università nel 1981, quattro anni dopo la scoperta della vita in prossimità delle fumarole idrotermali. Essendo figlia di due insegnanti che l’avevano cresciuta “a pane e Jules Verne – racconta – tutto quello era un grande richiamo per la ragazzina che c’è in me”. Studiare le profondità sotterranee non solo era un modo per “comprendere una parte del pianeta mai vista prima, e un tipo di vita che ancora non avevamo capito”, ma “era chiaramente destinato a buttar giù qualcuna delle barriere” che separano chimica, biologia, fisica e geologia, dando agli scienziati la possibilità di spaziare in tutti questi campi in combinazioni nuove e affascinanti.
Durante gli studi di Sherwood Lollar negli anni ottanta, e nelle fasi iniziali della sua carriera di geologa all’Università di Toronto nel decennio successivo, sono state via via scoperte, sempre più numerose, varie comunità microbiche sotterranee. L’enigma di quali fossero le fonti di sostentamento di queste forme di vita ha spinto alcuni ricercatori a proporre che potesse esserci “una biosfera profonda attivata dall’idrogeno”, piena di cellule che usavano come fonte energetica appunto l’idrogeno gassoso. (I microbi scoperti nei campioni estratti dalle profondità sotterranee erano spesso ricchi di geni per gli enzimi che servono a ricavare energia dall’idrogeno.)
Ci sono molti processi geologici che possono plausibilmente produrre idrogeno, ma quelli meglio studiati avvenivano solo ad alte temperature e pressioni. Fra di essi c’erano interazioni fra gas vulcanici, la degradazione di particolari minerali in presenza d’acqua e la serpentinizzazione, cioè l’alterazione di certi tipi di rocce della crosta terrestre in seguito a reazioni chimiche con l’acqua.

Nei primi anni duemila, Sherwood Lollar, Li-Hung Lin (oggi all’Università nazionale di Taiwan), Tullis Onstott alla Princeton University e i loro colleghi hanno trovato alte concentrazioni di idrogeno – “anzi, in certi casi incredibilmente alte”, precisa Sherwood Lollard – in acqua isolata dalle profondità della crosta terrestre in Sudafrica e in Canada. Ma in questi casi invocare la serpentinizzazione non bastava: i tipi di minerali di cui necessita questo processo spesso erano assenti. E non sembravano probabili neppure le altre possibilità, data l’assenza di attività vulcaniche recenti e flussi di magma.
“Dunque abbiamo cominciato a guardare e capire meglio le reazioni che producono idrogeno e il loro rapporto con la composizione chimica e mineralogica delle rocce di quelle parti del sottosuolo”, dice Sherwood Lollard.
Un indizio lo hanno trovato quando hanno scoperto che l’acqua intrappolata nelle rocce non conteneva solo grandi quantità di idrogeno ma anche elio, che indicava la presenza di particelle derivanti dal decadimento radioattivo di elementi come uranio e torio, e che scindevano le molecole d’acqua. Il fenomeno, la radiolisi dell’acqua, fu osservato per la prima volta nel laboratorio di Marie Curie ai primi del XX secolo, quando i ricercatori notarono che dalle soluzioni di sali di radio si sprigionavano bolle di idrogeno e ossigeno. Curie ne parlò come di “un’elettrolisi senza elettrodi”. (Ci volle qualche altro anno perché gli scienziati capissero che l’ossigeno proveniva dal perossido di idrogeno prodotto nel processo.)

di Jordana Cepelewicz/Quanta Magazine Nel 2006 Sherwood Lollard, Lin, Onstott e collaboratori hanno proposto che le comunità microbiche sotterranee del Sudafrica e del Canada si procurassero l’energia necessaria alla sopravvivenza dall’idrogeno prodotto per radiolisi. Così ha avuto inizio la loro lunga ricerca mirata a chiarire quanto la radiolisi possa essere importante per la vita negli ambienti naturali.
“Un sistema del tutto autosostenuto”
Per gran parte del decennio successivo, i ricercatori hanno prelevato campioni dagli acquiferi profondi in vari siti minerari, ponendo poi la complessa composizione chimica dei fluidi in rapporto con la natura geologica delle rocce circostanti. In alcuni casi, l’acqua intrappolata sotto la crosta terrestre in Canada era rimasta isolata dalla superficie per più di un miliardo di anni (e forse anche per due). In quell’acqua c’erano batteri, tuttora decisamente vivi.
“Doveva essere un sistema del tutto autosostenuto”, osserva Mustard. Andando per eliminazione, la radiolisi sembrava una possibile fonte di energia, ma era possibile che fosse sufficiente a sostenere la vita?
Nel 2014, quando hanno combinato i risultati dei laboratori di chimica nucleare con i modelli della composizione minerale della crosta, Sherwood Lollard e colleghi hanno scoperto che la radiolisi e altri processi probabilmente potevano produrre enormi quantitativi di idrogeno nel sottosuolo superficiale: tanto quanto ne proviene, si ritiene, dagli ambienti idrotermali e da altre fonti nei fondi marini di profondità. “Abbiamo raddoppiato i valori stimati per la produzione di idrogeno dovuta a reazioni tra acqua e rocce nel pianeta”, dice Sherwood Lollard.
I microbi possono usare direttamente l’idrogeno prodotto dalla radiolisi, ma questa è solo metà della storia: per sfruttarlo appieno hanno bisogno, accanto all’idrogeno come donatore di elettroni, di un’altra sostanza che faccia da accettore. Gli scienziati sospettavano che i microbi la trovassero nei composti che si formano quando il perossido d’idrogeno e altri radicali ossigenati prodotti dalla radiolisi reagiscono con i minerali circostanti. In un lavoro pubblicato nel 2016, hanno mostrato che il perossido d’idrogeno proveniente dalla radiolisi interagiva probabilmente con i solfuri contenuti nelle pareti di una miniera canadese, producendo solfato, che è un accettore di elettroni. Sherwood Lollard e colleghi, tuttavia, non avevano ancora le prove che le cellule sfruttassero appunto il solfato per ricavare energia.

Nel 2019, finalmente, le hanno ottenute. Coltivando i batteri trovati nelle acque profonde delle miniere, sono riusciti a mostrare che i microbi usavano sia l’idrogeno sia il solfato. Acqua, un po’ di decadimento radioattivo, un po’ di solfuri “ed ecco un sistema costante di produzione di energia che può durare per miliardi di anni… come oasi ambientale di abitabilità”, nota Jesse Tarnas, planetologo e borsista post-dottorato alla NASA.
Nel lavoro pubblicato lo scorso febbraio, Sherwood Lollar e colleghi hanno dimostrato che la radiolisi fa andare avanti non solo i cicli dell’idrogeno e dello zolfo sulla Terra, ma anche il ciclo più strettamente associato con la vita, quello del carbonio. L’analisi dei campioni d’acqua della stessa miniera canadese ha rivelato concentrazioni assai alte di acetato e formiato, composti organici in grado di sostenere la vita batterica. Le misurazioni della loro composizione isotopica indicano poi che questi composti sono generati per via abiotica. L’ipotesi dei ricercatori è che i prodotti della radiolisi reagiscano con alcuni minerali carbonatici delle rocce, producendo i forti quantitativi di molecole a base di carbonio osservati.
Per consolidare l’ipotesi, il gruppo di Sherwood Lollard aveva bisogno di ulteriori prove. Che sono arrivate appena un mese dopo. Un gruppo di chimici nucleari guidati da Laurent Truche, geochimico all’Università di Grenoble Alpes, e Johan Vandenborre dell’Università di Nantes si erano impegnati indipendentemente nello studio di laboratorio della radiolisi. Nel lavoro, pubblicato a marzo, hanno determinato con esattezza il meccanismo e la resa della radiolisi in presenza di carbonato disciolto. Hanno misurato le concentrazioni esatte di vari sottoprodotti, compreso acetato e formiato; e le quantità e i tassi di formazione da essi registrati sono in accordo con quanto osservato in natura da Sherwood Lollar nelle fratture profonde delle rocce.
Sotto il fondo del mare
Mentre Sherwood Lollard effettuava le sue ricerche sul campo nel sottosuolo continentale profondo, qualche scienziato ha cercato di capire gli effetti che può avere la radiolisi al di sotto del fondo marino. Il più eminente, Steve D’Hondt, geo-microbiologo dell’Università del Rhode Island, ha pubblicato a febbraio, insieme alla sua dottoranda Justine Sauvage e altri colleghi, i risultati di quasi due decenni di studi dettagliati, mostrando che la radiolisi è importante nel sostenere la vita al di sotto del fondo dei mari.
Nel 2010, D’Hondt e Fumio Inagaki, geo-microbiologo dell’Agenzia giapponese per le scienze e tecnologie marine e della terra, hanno effettuato una campagna di perforazione che ha prelevato campioni di sedimenti profondi sotto il fondale di vari mari del mondo. In seguito, D’Hondt e Sauvage hanno posto in sospensione in acqua decine di tipi di sedimenti, e poi li hanno esposti a diversi tipi di radiazioni; trovando, ogni volta, che la quantità di idrogeno che veniva prodotta era assai più elevata rispetto a quando si irradiava acqua pura. I sedimenti amplificavano i prodotti della radiolisi. E “le rese erano assurdamente alte”, dice D’Hondt. In certi casi, la presenza di sedimenti nell’acqua aumentava la produzione di idrogeno di un fattore quasi pari a 30.

“Certi minerali sono veri e propri centri di produzione radiolitica di idrogeno”, osserva D’Hondt. “Convertono con grande efficienza l’energia delle radiazioni in energia chimica che può essere sfruttata dai microbi.”
Eppure, D’Hondt e colleghi hanno trovato solo quantità minime di idrogeno nelle carote di sedimenti ottenute dalle perforazioni. “Tutto l’idrogeno che viene prodotto scompare”, dice D’Hondt. I ricercatori pensano che sia consumato dai microbi che popolano i sedimenti.
Secondo i loro modelli, nei sedimenti profondi di età superiore a qualche milione di anni, l’idrogeno radiolitico è prodotto e consumato più rapidamente della materia organica, il che fa della radiolisi dell’acqua la principale fonte di energia disponibile nei sedimenti più antichi.
Anche se la radiolisi dell’acqua rende conto solo dell’uno o due per cento dell’energia totale disponibile nell’ambiente globale dei sedimenti marini – il rimanente 98 per cento viene dal carbonio organico, consumato prevalentemente quando i sedimenti sono ancora recenti – i suoi effetti restano decisamente notevoli. “Sarà pure un processo lento – rileva Doug LaRowe, planetologo della Southern California – ma dal punto di vista geologico, e nel tempo geologico… a lungo andare si accumula.”
Questo vuol dire che la radiolisi “è una fondamentale fonte di energia biodisponibile per un significativo microbioma del pianeta”, spiega Sauvage, non solo nei continenti ma anche sotto gli oceani. “È davvero notevole.”
Un laboratorio naturale sulle origini della vita
È possibile che l’importanza scientifica, appena riconosciuta, della radiolisi non stia solo nel fatto che alimenta la vita in ambienti estremi. Potrebbe, infatti, darci anche qualche lume sui processi di sintesi abiotica di sostanze organiche che potrebbero aver aperto la strada all’origine della vita sulla Terra e altrove.
Sherwood Lollard ha trovato molto stimolante la recente osservazione del suo gruppo che, nei sistemi ambientali chiusi nei pressi delle miniere canadesi, la maggior parte dei composti organici è stata prodotta, a quanto pare, per via abiotica. “È uno dei pochi posti del pianeta in cui la vita non ha già lasciato il suo segno, contaminando tutto”, dice. “E sul nostro pianeta questi luoghi sono davvero rari e preziosi.”
Il particolare valore di questi luoghi è dovuto, in parte, al fatto che possono essere “qualcosa di analogo a quella che potrebbe essere stata la zuppa prebiotica che doveva esserci prima del sorgere della vita sulla nostra Terra”, continua. Anche se la vita non è nata in essi – come scenario della storia delle origini continuano a essere più probabili altre regioni del pianeta, più ricche di energia, come le fumarole idrotermali – questo tipo di ambienti sotterranei ha offerto una zona sicura in cui la vita poteva sostentarsi per lunghi periodi, ben lontana dai pericoli della superficie (come gli impatti di meteoriti e gli alti livelli di radiazione che imperversavano sulla Terra primordiale).

di Jordana Cepelewicz/Quanta Magazine Modelli ed esperimenti hanno mostrato che anche sistemi semplici (per esempio, costituiti solo di idrogeno, anidride carbonica e solfato) possono portare a reti alimentari microbiche estremamente intricate; aggiungere alla mistura formiato e acetato provenienti dalla radiolisi potrebbe allargare di molto il possibile panorama ecologico. E da essi, visto che possono dare origine a composti organici più complessi, possono formarsi sistemi ancor più diversificati. “È importante vedere che la vita procede a questi livelli di complessità”, dice Cara Magnabosco, geobiologa all’Istituto federale svizzero di tecnologia di Zurigo, “anche in quello che magari si potrebbe considerare un ambiente assai semplice e molto povero di energia”.
“Diciamo pure che [la radiolisi]può portare solo a composti organici di base, come formiato e acetato”, spiega LaRowe. “Se spostiamo questi composti in una diversa situazione ambientale, forse lì potranno reagire per formare qualcos’altro. E diventare un punto di partenza o una materia prima per reazioni diverse in una situazione diversa.” E questo potrebbe anche servire agli scienziati per fare un passo avanti verso la comprensione di come si siano prodotti gli amminoacidi e altri importanti blocchi costitutivi della vita.
Sherwood Lollard collabora ora con altri ricercatori, fra cui colleghi del progetto CIFAR Earth 4D, per studiare i modi in cui le molecole organiche presenti nelle antiche acque canadesi potrebbero far crescere in complessità le interazioni chimiche in questione. Nel lavoro che sperano di pubblicare prima della fine dell’anno, “mostriamo come la coevoluzione delle sostanze organiche e dei minerali sia la chiave della diversificazione di questi composti organici”, dice Bénédicte Menez, geobiologa all’Istituto di fisica terrestre di Parigi, tra gli autori principali della ricerca. Il suo obiettivo è chiarire come possano essersi formate strutture organiche più complicate, che poi avrebbero potuto avere un ruolo in qualcuno dei più antichi metabolismi microbici.
Anche gli astrobiologi si stanno rendendo conto di quanto potrebbe essere cruciale considerare la radiolisi nello stabilire i vincoli per l’abitabilità di pianeti e satelliti in tutto il sistema solare e nel resto della galassia. Luce solare, alte temperature e altre condizioni, insomma, potrebbero non essere strettamente necessarie per sostenere la vita extraterrestre. La radiolisi dovrebbe essere praticamente diffusa su ogni pianeta roccioso che contenga acqua nel sottosuolo.
Prendiamo Marte. In due studi, uno pubblicato un paio d’anni fa e l’altro nello scorso aprile, Tarnas, Mustard, Sherwood Lollard e altri ricercatori hanno tradotto le determinazioni quantitative in corso sulla radiolisi terrestre in termini del sottosuolo marziano. E hanno trovato che, in base alla composizione minerale del pianeta e altri parametri, Marte potrebbe oggi essere in grado di sostenere ecosistemi microbici analoghi a quelli presenti sulla Terra grazie ai soli processi radiolitici. Ricercatrici e ricercatori hanno identificato alcune regioni del pianeta che hanno buone probabilità di ospitare le massime concentrazioni microbiche, offrendo un elemento per guidare le decisioni su dove indirizzare le future missioni.
“Per me è davvero affascinante – dice Inagaki – siamo arrivati a un’epoca in cui per studiare la vita microbica dentro il pianeta Terra e in altri mondi dell’universo c’è bisogno della fisica delle particelle.”
—————
(L’originale di questo articolo è stato pubblicato il 24 maggio 2021 da QuantaMagazine.org, una pubblicazione editoriale indipendente online promossa dalla Fondazione Simons per migliorare la comprensione pubblica della scienza. Traduzione di Alfredo Tutino, editing a cura di Le Scienze. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati)