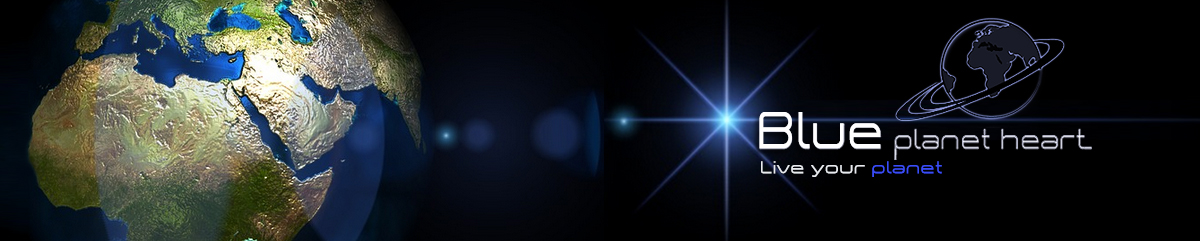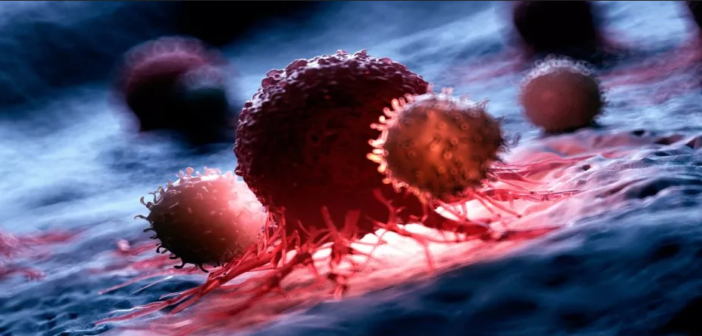Useremo batteri OGM contro il cancro
Uno studio pilota indica che è possibile ridurre una massa tumorale iniettandovi dei batteri geneticamente modificati che veicolano un mini-anticorpo in grado di inattivare una difesa delle cellule cancerose dall’attacco del sistema immunitario
di Valentina Murelli
www.lescienze.it
Iniettare batteri OGM in un tumore per renderlo vulnerabile all’azione del sistema immunitario: può sembrare una strategia di lotta contro il cancro troppo complessa, e azzardata, ma non è quello che hanno pensato l’immunologo Nicholas Arpaia e l’esperto in biologia sintetica Tal Danino (entrambi alla Columbia University di New York) quando hanno deciso di unire le forze per tentare proprio questa via.
I risultati, pubblicati alcune settimane fa su “Nature Medicine”, hanno dato loro ragione: almeno nei topi, l’approccio sembra funzionare, portando alla regressione del tumore.
A dire il vero non è la prima volta che a qualcuno viene in mente di usare batteri nella terapia del cancro: a fine Ottocento – un’epoca nella quale non si poteva fare molto contro questa malattia, se non asportarla per via chirurgica – ci aveva già pensato il chirurgo americano William Coley, che iniziò a iniettare nei suoi pazienti con tumore streptococchi uccisi da calore. L’idea poteva sembrare balzana, ma si basava su resoconti aneddotici di malati di cancro guariti dopo aver contratto un’infezione.
“Oggi sappiamo che i batteri possono esercitare una certa attività antitumorale, perché la loro presenza induce una risposta immunitaria aspecifica che si rivolge anche contro le cellule tumorali”, spiega a “Le Scienze” Maria Rescigno, responsabile dell’Unità di immunologia delle mucose e microbiota dell’Humanitas Research Hospital di Milano, che ricorda però che i primi tentativi di Coley diedero risultati molto variabili, e non convinsero la comunità scientifica dell’epoca.
Quasi 130 anni dopo, tuttavia, si stanno moltiplicando i tentativi basati su quell’intuizione, anche se con obiettivi e metodologie alquanto differenti. Lo stesso gruppo di ricerca di Rescigno (allora all’Istituto europeo di oncologia, IEO) aveva sviluppato nel 2013 un sistema basato su salmonelle usate come “missili” intelligenti per veicolare in modo specifico in un tumore molecole citotossiche, in grado di uccidere le cellule cancerose.
Nel 2015, invece, FDA ed EMA (le agenzie che si occupano della regolamentazione dei farmaci negli Stati Uniti e in Europa) hanno riconosciuto come indicato per il melanoma metastatico un trattamento con virus oncolitici OGM, che oltre a distruggere le cellule tumorali rilasciano una proteina che stimola il sistema immunitario. Ora è il turno di Arpaia e Tanino, con un lavoro che fonde i progressi tecnologici degli ultimi anni nel campo della biologia sintetica con i successi della terapia antitumorale più promettente del momento: l’immunoterapia.

Il fatto è che il nostro sistema immunitario è già in grado, da solo, di riconoscere e distruggere gran parte delle cellule tumorali che si formano nell’organismo (se così non fosse, svilupperemmo molti più tumori di quanto di fatto avviene). A volte, però, il tumore riesce a eludere questo controllo, nascondendosi grazie a una serie di trucchi molecolari, tra cui l’espressione di una proteina chiamata CD47, che costituisce un vero e proprio segnale don’t eat me, “non mangiarmi”, rivolto alle cellule immunitarie.
Questa proteina è tipicamente presente sulla superficie dei globuli rossi del sangue, per avvisare il sistema immunitario di lasciarli in pace almeno finché sono giovani e in buona salute. A mano a mano che invecchiano, i globuli rossi perdono le loro CD47, diventando così preda delle cellule immunitarie, lasciando spazio a globuli rossi nuovi. In seguito a mutazioni geniche, però, anche alcune cellule tumorali possono acquisire il segnale “non mangiarmi”, esponendo in superficie proteine CD47 che non dovrebbero esserci e che le proteggono dal fisiologico attacco del sistema immunitario.
Negli ultimi anni, in molti laboratori si è cercato un modo per spegnere questo segnale, arrivando alla messa a punto di un anticorpo specifico contro la proteina CD47 che svolge proprio questa funzione: attaccandosi alla proteina presente sulle cellule tumorali, la maschera, dando il via libera all’attacco immunitario.

Il problema è che questo anticorpo è troppo grande per essere iniettato con efficacia in un tumore e comporta effetti collaterali importanti, in particolare anemia e cospicua riduzione delle piastrine, se iniettato per via sistemica. Ed è proprio qui che si inserisce l’innovativo lavoro dell’équipe guidata da Arpaia e Danino.
Un mini-gene per un mini-anticorpo
Punto di partenza del nuovo approccio è stato lo sviluppo, circa tre anni fa, di una versione miniaturizzata dell’anticorpo contro CD47, chiamata nanobody e codificata da un mini-gene che può essere facilmente inserito nel genoma di un batterio per farglielo produrre in grandi quantità. I ricercatori americani hanno usato dei comunissimi batteri Escherichia coli, programmandoli anche in modo da andare incontro a lisi (in pratica un’autodistruzione) una volta che abbiano raggiunto una certa densità di popolazione.
Per riuscirci hanno sfruttato un meccanismo molecolare chiamato quorum sensing, che è spesso usato dai batteri per comunicare tra di loro e che in questo caso aveva l’obiettivo di evitare una moltiplicazione fuori controllo dei microrganismi. Il passo successivo è stato iniettarli nei tumori sottocutanei di alcuni topolini, dove a ondate (cioè via via che i batteri stessi si lisavano dopo aver raggiunto una certa densità) venivano liberati i nanobody contro CD47.

Come sperato, i ricercatori hanno osservato un’effettiva restrizione di questi tumori, sia perché il blocco delle proteine CD47 da parte dei nanobody rendeva le cellule tumorali visibili al sistema immunitario, sia perché l’autodistruzione dei batteri rilasciava frammenti in grado di sollecitare anche una risposta immunitaria generalizzata. Non solo: Arpaia, Danino e collaboratori hanno anche notato la riduzione di altri tumori dispersi nei topolini, oltre a quelli in cui erano stati iniettati i batteri: è il cosiddetto “effetto abscopal”, che fa pensare a un possibile impiego anche per il controllo di metastasi.
“Nel complesso sono risultati davvero interessanti”, commenta Rescigno, sottolineando per esempio che il sistema di lisi automatica dei batteri iniettati potrebbe ridurre il rischio di tossicità delle terapie (è meno probabile che i batteri e il loro carico terapeutico escano dal tumore e vadano in giro per l’organismo). “Inoltre – afferma l’immunologa – si potrebbe pensare di caricare i batteri anche con altre molecole utili nella lotta contro il cancro, in un’ottica di terapia combinata. Per esempio molecole citotossiche o, soprattutto, inibitori dei checkpoint immunologici”.
Il riferimento in questo caso è all’ultima frontiera dell’immunoterapia, alla quale è andato nel 2018 il premio Nobel per la medicina e la fisiologia. “Il cancro infatti – prosegue Rescigno – non si difende dal sistema immunitario solo nascondendosi, ma anche neutralizzandolo attraverso l’iperattivazione dei suoi freni naturali (i checkpoint immunologici, appunto: molecole che lo mettono a riposo dopo lo svolgimento di un compito, per evitare che vada fuori controllo). Da alcuni anni, però, disponiamo di inibitori specifici di questi freni, che hanno rivoluzionato la terapia di alcuni tumori di particolare aggressività, come il melanoma metastatico o certe forme di tumore del polmone e del rene”.
Ma attenzione: per quanto i risultati di Arpaia e Tanino appaiano incoraggianti, questo non significa che un eventuale passaggio dai topolini all’essere umano sia semplice. “Ci sono limiti metodologici – conclude Rescigno – a partire dal fatto che non tutti i tumori sono raggiungibili con un’iniezione. E potrebbero esserci limiti culturali, perché non è scontata l’accettazione di un approccio che prevede l’introduzione nell’organismo di batteri vivi, per quanto sotto controllo”.