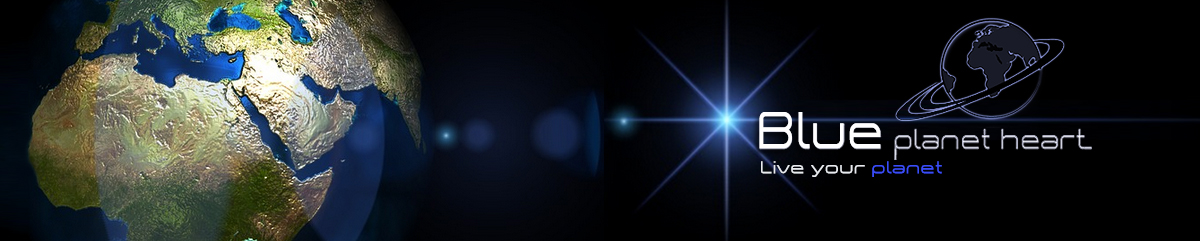Perché c’è ancora chi non crede ai cambiamenti climatici?
Anche se le prove sono schiaccianti, in molti negano i rischi che il nostro pianeta sta correndo. Psicologi sociali, scienziati cognitivi e neuroeconomisti spiegano perché.
www.focus.it
Gli studi sono moltissimi, le prove schiaccianti, gli scienziati concordi e le conseguenze già visibili. Eppure, molte persone nel mondo ritengono che il cambiamento climatico sia un’invenzione, o perlomeno che si tratti di un evento non imminente e tutto sommato meno pericoloso di quanto non indichino i dati. Per questo, da tempo psicologi sociali, scienziati cognitivi e neuroeconomisti si interrogano su quali siano le ragioni del negazionismo climatico.
La risposta si trova nel funzionamento del cervello. «Per attivare il nostro sistema di allarme, non basta che uno stimolo sia percepito come generalmente negativo, deve anche costituire un pericolo», spiega Simona Sacchi, psicologa sociale dell’Università Milano Bicocca, che lavora sulla percezione del cambiamento climatico. «Per questo rispondiamo prontamente alle minacce intenzionali, che sono sentite come imminenti e capaci di attaccare la nostra incolumità fisica, o anche quelle di natura morale e sociale, i cui effetti si ripercuotono sul buon funzionamento della società.»
Distanza psicologica. Il cambiamento climatico, invece, non scatena simili reazioni perché ci appare distante, sia nel tempo sia nello spazio. «Gli effetti sull’ambiente delle nostre azioni non sono immediati, e forse non saremo neppure noi a subirli», continua Simona Sacchi. Persino quando le previsioni sono vicine in termini temporali, la distanza psicologica rimane. «Anche se mancano ormai solo tre anni al 2020 – data entro la quale, secondo molti scienziati, bisognerebbe ridurre drasticamente le emissioni di gas serra in atmosfera – quella data è percepita ancora come lontana, così come distanti geograficamente ci appaiono il Polo Nord, il cui ghiaccio si sta sciogliendo, e il Sudest asiatico, sconvolto dalle inondazioni. È questo divario spazio-temporale a determinare l’atteggiamento distaccato verso le tematiche ambientali», afferma Simona Sacchi.
Questa “distanza percepita” spinge a non credere a previsioni tanto nefaste, come sono quelle sugli effetti dei cambiamenti climatici, atteggiamento amplificato dal meccanismo difensivo della rimozione, che usiamo inconsciamente in molti contesti per scacciare le preoccupazioni. «È un processo del tutto analogo a quello che mettiamo in atto nei confronti di altri pensieri ugualmente paurosi, come quello della morte, per esempio», aggiunge la studiosa.
Ma c’è dell’altro. Nel prendere le decisioni, gli individui utilizzano “scorciatoie del pensiero”, le cosiddette euristiche, descritte per la prima volta dagli psicologi Amos Tversky e Daniel Kahneman, quest’ultimo premio Nobel per l’economia nel 2002. Per esempio, tendiamo a considerare e a valutare i rischi futuri sulla base di quanto è accaduto in passato e della nostra capacità di immaginarci l’evento avverso.
«Nel caso del cambiamento climatico, però, fatichiamo a capire l’esatto legame causale tra decisioni passate e l’attuale scenario di crescente desertificazione di alcune aree», fa notare il neuroeconomista Giorgio Coricelli, della USC University of Southern California. Per questo il rischio che possano verificarsi eventi catastrofici dovuti al surriscaldamento ci appare molto piccolo.
Come si comporta il cervello di fronte alle basse probabilità? «Da una parte tende a sovrastimarle, perché l’impatto che un esito infausto può avere su di una persona può mettere in gioco la sua stessa sopravvivenza», afferma Giorgio Coricelli. Del resto, stipuliamo assicurazioni per eventi che hanno una bassissima probabilità di accadere, ma sono potenzialmente devastanti.
Al tempo stesso, però, entrano in gioco due errori di ragionamento che si fanno spesso, quando si valuta ciò che accade: «Quello dell’ottimismo, che ci porta a considerare il futuro in una prospettiva molto più rosea di quanto non sarebbe lecito supporre, e quello della procrastinazione, che ci vede impazienti di riscuotere subito un guadagno (ad esempio, il consumo di risorse) e incapaci di attendere una maggior ricompensa futura (salvare il pianeta)».
Secondo Coricelli, a influenzare il giudizio c’è anche il fatto che il cambiamento climatico non riguarda più il singolo, ma il gruppo. «Qui non c’è il rischio che un fulmine mi colpisca, ma che un’inondazione ci travolga tutti. E questo per il nostro cervello fa la differenza. Lo stare insieme modifica la percezione del rischio, riducendola. Prudenti da soli, in gruppo ci sentiamo più sicuri e diventiamo più audaci. I nostri studi hanno dimostrato che nei due diversi contesti, sociale e individuale, valutiamo in modo differente il peso relativo di guadagni e perdite.»