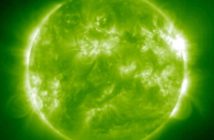28 luglio 1883, la catastrofe di Casamicciola sull’isola d’Ischia che causò 2.333 morti
a cura di Cecilia Ciuccarelli e Dante Mariotti (INGV, Sezione di Bologna)
ingvterremoti.wordpress.com
«Ccà pare Casamicciola...»: con queste parole il protagonista di Natale in casa Cupiello, la celebre commedia scritta da Eduardo De Filippo tra il 1931 e il 1932, descrive il caos cui si trova davanti entrando nella stanza dove poco prima, durante una furiosa lite tra la moglie e la figlia, sono finiti in pezzi stoviglie e soprammobili ed è stato «scassato» il presepe che stava costruendo con impegno maniacale. Perché De Filippo utilizza quel paragone per definire il putiferio causato dalla lite?
In realtà, già a partire dagli ultimi anni dell’Ottocento, soprattutto nel linguaggio popolare delle regioni dell’Italia centro-meridionale, il termine casamicciola, derivato dal toponimo della cittadina termale dell’isola d’Ischia distrutta dal terremoto del 28 luglio 1883, aveva assunto un significato figurato per indicare una situazione di caos, di grande sovversione e sconquasso.
Augusto Placanica ha analizzato in un eruditissimo saggio la genesi e i motivi che hanno portato all’uso del termine casamicciola come metafora di disordine imprevedibile. Secondo Placanica, a differenza delle molte località italiane devastate da un terremoto o da un altro disastro naturale, la catastrofe di Casamicciola del 1883 colpì l’immaginario collettivo popolare perché fu distrutto un luogo di straordinaria bellezza naturale, dedicato alla salute e allo svago vacanziero, frequentato soprattutto da una clientela d’élite costituita da facoltosi aristocratici e ricchi borghesi di tutta Italia e di gran parte d’Europa. L’uso di tale metafora fu così diffuso nella prima metà del Novecento, da venire registrato fino a tutti gli anni Sessanta-Settanta, con l’iniziale rigorosamente minuscola, dai più importanti dizionari della lingua italiana. Ora sopravvive soltanto tra le generazioni più anziane e il termine non viene più considerato dai dizionari più recenti: lo si può però ancora ritrovare nel Vocabolario dell’Istituto Treccani consultabile in rete (http://www.treccani.it/vocabolario/casamicciola/).
L’ipotesi illustrata da Placanica è del tutto condivisibile; tuttavia, forse, anche il caos organizzativo che caratterizzò nel 1883 l’opera di soccorso e la frequente ripetizione degli eventi sismici che nel corso dell’Ottocento avevano colpito Casamicciola giocarono un ruolo rilevante nel fare di casamicciola un nome comune astratto entrato nel patrimonio lessicale della lingua italiana.
I precedenti
Già a partire dalla seconda metà del Settecento, sono ricordati numerosi terremoti che colpirono Casamicciola e il suo territorio. Il 14 luglio 1762, l’architetto Luigi Vanvitelli, che si trovava a Casamicciola per un periodo di cure, fu testimone di due scosse di terremoto quasi consecutive poco dopo le 9 della mattina. Secondo le gazzette dell’epoca, ci furono danni notevoli agli edifici della cittadina. Verso la fine del secolo, intorno alle ore 17:30 del 18 marzo 1796, un violento terremoto fece crollare circa 50 case nei dintorni della chiesa parrocchiale di S.Maria Maddalena, nella parte meridionale di Casamicciola Alta: sotto le rovine morirono 7 persone e molte altre furono ferite.
Ancora più distruttivo fu l’evento del 2 febbraio 1828 su cui si hanno notizie precise grazie alla presenza sull’isola del chimico Nicola Covelli che stava svolgendo uno studio sulle acque termali. Covelli descrisse gli effetti del terremoto in due lettere al segretario perpetuo dell’Accademia delle Scienze di Napoli, Teodoro Monticelli, e in una estesa relazione.

Pagina iniziale della lettera scritta da Nicola Covelli il 3 febbraio 1828 e indirizzata a Teodoro Monticelli (Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria).
La scossa distruttiva, avvenuta alle ore 10:15, colpì la parte nord-occidentale dell’isola d’Ischia, causando crolli estesi in un’area di pochi km quadrati. Le località più danneggiate furono Casamicciola e Fango (frazione del comune di Lacco Ameno), dove collassarono numerosi edifici causando 29 morti e circa 50 feriti. Danni furono rilevati anche a Lacco Ameno e a Fontana. In particolare, a Casamicciola tutti gli edifici della parte alta dell’abitato furono gravemente danneggiati e molti crollarono; nella chiesa parrocchiale di S.Maria Maddalena cadde la prima volta della navata centrale schiacciando molte persone che assistevano a una funzione religiosa. Charles Lyell, che visitò Casamicciola nell’ottobre successivo, riferì che tutte le case erano ancora prive di tetto.
Dopo poco più di dieci anni, il 6 marzo 1841 alle ore 13, una forte scossa causò lesioni negli edifici di Casamicciola e qualche danno minore a Lacco Ameno.
Ulteriori forti scosse, senza danni rilevanti, furono sentite nel 1852 e nel 1863; ma il 14 agosto 1867 Casamicciola subì nuovi danni. Di questo terremoto, avvenuto poco dopo la mezzanotte, che causò sconnessione di murature, caduta di calcinacci e di parti di ornato e una grave lesione al campanile della chiesa parrocchiale, furono testimoni il celebre drammaturgo norvegese Henrik Ibsen e lo scrittore danese Vilhelm Bergsøe che ne pubblicò la memoria nel 1907.
Infine, solo due anni prima del 1883, il 4 marzo 1881, Casamicciola aveva subito un nuovo violento evento sismico. Anche questo terremoto causò effetti distruttivi in un’area molto limitata della parte settentrionale dell’isola d’Ischia. Complessivamente risultarono danneggiati 10 edifici pubblici e 883 privati, di cui 290 crollarono totalmente. Secondo i dati statistici rilevati dal Comitato di soccorso, pubblicati nella relazione redatta da Giuseppe Margotta, i vani crollati totalmente furono 834, quelli resi pericolanti e inagibili 117, quelli lesionati in modo considerevole 2952. I morti furono 127: 121 a Casamicciola, 5 a Fango, uno a Lacco Ameno, le tre località dove ci furono gli effetti più gravi. Danni meno gravi (lesioni e dissesti nelle murature) furono rilevati a Barano, Buonopane, Fiaiano, Fontana, Monterone e Tironi; a Forio ci furono danni leggeri.

Distribuzione degli effetti del terremoto del 4 marzo 1881 secondo CFTI5Med.