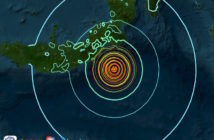Il rischio e la sua percezione
Sempre più spesso, oggigiorno, sentiamo parlare di percezione del rischio di “qualcosa”: criminalità, malattie, terrorismo, economico, etc. Ma cosa s’intende esattamente con il termine “percezione”?
A cura di Massimo Crescimbene – psicologo (INGV – Roma1)
ingvterremoti.wordpress.com
Sempre più spesso, oggigiorno, sentiamo parlare di percezione del rischio di “qualcosa”: criminalità, malattie, terrorismo, economico, etc. Ma cosa s’intende esattamente con il termine “percezione”? Quali sono i principali approcci scientifici allo studio della percezione? E inoltre, cosa intendono i sismologi con il termine rischio sismico e perché questo termine è spesso confuso o considerato sinonimo di pericolosità e pericolo? Introdurremo, infine, lo studio sulla percezione del rischio sismico in Italia realizzato dall’INGV in questi ultimi anni, i cui risultati saranno oggetto di successivi articoli di questa rubrica.
La percezione
Contrariamente a quanto siamo abituati a pensare, la nostra percezione del mondo non è un dato “oggettivo”, al contrario la percezione è fortemente influenzata – a volte addirittura distorta – dalla nostra mente e dalla rappresentazione che abbiamo del mondo. Gli esempi classici riguardano la percezione visiva. Immagini come quelle riportate di seguito (Figura 1) dimostrano chiaramente come il nostro modo di vedere è guidato oltre che dal senso della vista (in questo caso) anche dal nostro cervello che elabora le informazioni sensoriali secondo il contesto, la luce, il colore, le esperienze pregresse.
Figura 1 – A sinistra: variazione di percezione della lunghezza di un segmento in base alla variazione del contesto. A destra: il triangolo bianco viene percepito anche se in realtà non è disegnato.
Questo stesso modello percettivo – cioè guidato dalla nostra mente – influenza la nostra percezione ad un livello cognitivo complesso. In un famoso esperimento Loftus e Palmer (1974) sottoposero alcuni gruppi di soggetti alla visione di un filmato di due auto che si scontravano (vedi filmato). Subito dopo la visione del filmato lo sperimentatore formulava ai soggetti la seguente domanda, nella quale utilizzava un termine diverso: “A quale velocità andavano le due auto quando si sono fracassate/scontrate/colpite/urtate/toccate?” I due autori si accorsero che le risposte dei soggetti variavano sulla base del termine che era stato utilizzato nel porre la domanda, e che si ottenevano stime della velocità delle auto molto diverse. Nella tabella seguente (Tabella 1) sono riportati i risultati dell’esperimento, con una valutazione della velocità media delle risposte dei soggetti che varia da 31,8 Km/h se nella domanda si usa il termine “toccate” a 40,8 quando si usa il termine “fracassate”.
Termine usato nella domanda |
Velocità stimata |
Fracassate (Smashed) |
40,8 |
Scontrate (Collided) |
39,3 |
Colpite (Bumped) |
38,1 |
Urtate (Hit) |
34,0 |
Toccate (Contacted) |
31,8 |
Tabella 1 – Percezione della velocità delle auto nell’esperimento di Loftus e Palmer del 1974.
Ulteriori esempi di influenza sulla nostra percezione sono quelli conosciuti come teoria del contesto, che ha valso il premio Nobel per l’economia allo psicologo Daniel Kahneman nel 2002. Nel suo studio originale del 1981, condotto insieme a Amos Twesky, conosciuto come “Asian Desease Problem”, i due autori ponevano i seguenti quesiti a due gruppi di soggetti.
Gli USA si stanno preparando a fronteggiare l’insorgere di una malattia asiatica insolita, che dovrebbe colpire 600 persone. Per combattere la malattia sono stati proposti due programmi alternativi. Al primo gruppo di soggetti veniva chiesto di scegliere tra questi due possibili programmi.
-
Programma A: 200 persone saranno salvate.
-
Programma B: C’è una probabilità di 1/3 che 600 persone saranno salvate e una probabilità di 2/3 che nessuna persona sarà salvata.
In questo quadro decisionale il 72% dei partecipanti preferiva il programma A, mentre il restante 28% optava per il programma B. Ad un secondo gruppo di soggetti veniva chiesto di scegliere tra questi due possibili programmi.
-
Programma C: 400 persone moriranno.
-
Programma D: C’è una probabilità di 1/3 che nessuno muoia e una probabilità di 2/3 che moriranno 600 persone.
In questo secondo quadro decisionale, il 78% preferiva il programma D, mentre il restante 22% sceglieva il programma C.
I programmi A e C sono identici, così come i programmi B e D. La modifica del quadro decisionale tra i due gruppi di partecipanti ha prodotto un’inversione di preferenza: quando i programmi sono stati presentati in termini di vite salvate, i partecipanti hanno preferito il programma sicuro A (200 persone saranno salvate); quando i programmi sono stati presentati in termini di morti previste, i partecipanti hanno scelto la scommessa D (c’è la probabilità di 1/3 che nessuno muoia…).
Sulla base dei risultati ottenuti con questo tipo di esperimenti Tvesky e Kahneman hanno formulato la teoria del contesto (in inglese Frame Theory), che ritiene che le scelte siano effettuate dalle persone non sulla base di un effettivo calcolo delle probabilità, ma secondo il contesto in cui le scelte sono proposte. Gli autori hanno definito il primo un “contesto di guadagno” dove i soggetti manifestano una avversione al rischio (risk adversion); mentre il secondo è considerato un “contesto di perdite” dove le risposte da parte dei soggetti mostrano una tendenza alla ricerca del rischio (risk seeking). La teoria del prospetto ha integrato in una formulazione matematica gli aspetti più propriamente psicologici della valutazione individuale con il principio fondamentale della teoria dell’utilità attesa, secondo cui la scelta più razionale è quella che massimizza il prodotto del valore atteso di ogni evento per la sua probabilità.
In campo economico, prima delle ricerche di Tversky e Kahneman, si faceva esclusivo riferimento alla teoria della utilità attesa, che si basa sull’ipotesi che l’utilità di un agente, in condizioni di incertezza, possa essere calcolata come una media ponderata delle utilità in ogni stato possibile, utilizzando come pesi le probabilità del verificarsi dei singoli stati come stimate dall’agente (Von Neumann & Morgenstern, 1953).
Figura 2 – La funzione asimmetrica di valore di Kahneman e Tversky. Contrariamente alla tradizionale funzione di utilità, la funzione di valore viene definita rispetto alle variazioni della ricchezza. E’ più ripida rispetto alle perdite che rispetto ai guadagni, è concava nei guadagni e convessa nelle perdite. Questa proprietà della funzione di valore è alla base di numerose applicazioni pratiche, soprattutto a livello di marketing.